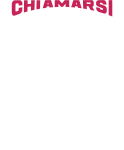Niente a che vedere con gli attaccanti patinati da copertina: Dario Hubner arrivava dal cantiere, montava infissi in alluminio e segnava gol a grappoli, dai campetti della Prima Categoria fino alla Serie A, sempre con lo stesso spirito operaio, quello che non si perde nei riflettori. Dario ha detto “no” alla Premier League per restare vicino alla sua famiglia, scegliendo Crema ad un contratto milionario. Oggi, a 58 anni, si gode la vita da nonno tra moto, funghi e sigarette elettroniche, ma lo sguardo è rimasto quello di sempre: limpido, diretto, umano. Come il suo tiro. Con lui abbiamo parlato del calcio che fu, di quello di oggi, di giovani, di nazionale e di un’umanità che sembra essersi persa. Ma che, a sentirlo parlare, forse possiamo ancora ritrovare.
Sono passati quattordici anni dal tuo ritiro: chi è e cosa fa oggi Dario Hübner nella vita privata?
“Dario Hübner fa il nonno. Esclusivamente il nonno. Poi ho quei due o tre hobby che mi piacciono e li porto avanti in maniera tranquilla, ma fare il nonno è quello che mi dà più soddisfazioni. Mi piace raccogliere funghi, andare un po’ a pesca, qualche giretto in moto… Però, davvero, essere nonno penso sia la più grande soddisfazione che possa esistere”.
Dario tu hai vestito maglie che hanno rappresentato la provincia profonda del calcio italiano: Cesena, Brescia, Piacenza… Che valore aveva per te il legame con la città e con la gente? Pensi che oggi un rapporto così esista ancora?
“Devo dirti che ai miei tempi il presidente, il magazziniere, l’allenatore… erano persone con cui lavoravi insieme e a cui volevi bene. Io i miei presidenti non li consideravo solo per lo stipendio: dopo un po’ diventavano persone a cui volevi bene davvero. Sapevi che ci tenevano alla squadra perché erano i primi tifosi. Lugaresi a Cesena, Corioni a Brescia, Garilli a Piacenza… Erano persone del posto. E quando perdevi una partita, sapevi che avresti fatto passare a loro un lunedì brutto. Eri il primo a starci male e la prima cosa che ti veniva in mente erano loro. C’era un rapporto d’amore. Poi ci tenevi alla maglia, e automaticamente così era verso i tifosi, così era verso i dipendenti della società. Si creava una sorta di famiglia. Ti volevi bene. Anche tra giocatori: c’era un ambiente familiare”.
Tu hai lavorato come fabbro fino a vent’anni, prima del grande salto nel calcio. Quanto ha inciso quella gavetta nel tuo percorso da calciatore?
“Credo che quando uno si deve guadagnare le cose, poi apprezza di più quello che ottiene. Io ho avuto la fortuna di arrivare in Serie A, però bisogna anche dire che a vent’anni giocavo in Prima Categoria. Poi ho fatto l’Interregionale, che oggi sarebbe la Serie D. Dopo due anni in C2, ho vinto il campionato e sono passato in C1, poi in Serie B… E ci ho giocato cinque anni, prima di arrivare in Serie A. Quindi non è che ho fatto tutto in due anni. Ci ho messo dieci anni per conquistarmi la Serie A. Dietro c’è un grande lavoro, una grande voglia di migliorarsi. Perché l’Hubner che giocava in Prima Categoria a vent’anni non era lo stesso dei trent’anni. Sono cambiato, ci ho lavorato sopra. È stato un percorso di dieci anni, fatto di sacrifici anche se, a dire il vero, fare il calciatore non lo considero proprio un sacrificio. Però dieci anni di lavoro sul campo per migliorarmi”.
Tu e Igor Protti siete gli unici ad aver vinto la classifica marcatori in Serie A, B e C1. Com’è cambiato, secondo te, il percorso dalle categorie inferiori fino alla massima serie?
“Oggi la Serie C dovrebbe essere una categoria in cui i giovani crescono, invece sembra quasi un punto d’arrivo. Vedo tanta pubblicità, specialmente sui social, ma i giocatori dovrebbero capire che la C deve essere un punto di partenza. Una volta arrivati in C, devono migliorarsi per arrivare in B o anche in A. Invece oggi sembra che la Serie C sia un traguardo. E non deve essere così. Deve essere uno stimolo continuo a migliorare”.
Nel tuo calcio c’erano libertà, intuizione, e anche tanta umanità. Oggi tutto è molto più scientifico e automatizzato, anche nella selezione dei giocatori. Che idea ti sei fatto su questo aspetto?
“Io mi ricordo che una volta c’erano i presidenti, qualche procuratore — non cinquantamila — e soprattutto i direttori sportivi leggevano l’almanacco come fosse il Vangelo. Se un giocatore faceva venti gol in Serie B, poteva salire in Serie A, perché aveva fatto bene. Se ne facevi cinque, era quasi impossibile salire. Oggi è tutto cambiato. Si cerca molto all’estero. Ma secondo me, in Italia, ci sono tanti giocatori validi. La Serie D e la Serie C devono essere i bacini da cui attingere per migliorare e portarli nelle categorie superiori. Altrimenti che senso ha avere la Serie D o la Serie C se poi andiamo a prendere cinquantamila stranieri anche in B e in A? Se vogliamo far crescere i nostri, dobbiamo anche cercarli, farli giocare e portarli nelle nostre squadre”.
Quel calcio lì ti permetteva anche di andare fuori dagli schemi: tu sei stato spesso associato al binomio “grappa e sigarette”. L’allora presidente del Brescia, Gino Corioni, disse che senza questi due elementi saresti stato il più forte di tutti. A distanza di anni, cosa ne pensi?
“No, non credo. All’epoca, negli anni ’90 e primi 2000, c’erano tantissimi attaccanti molto più forti di me. Quindi non era quello il problema. Ce n’erano di più forti, punto. La sigaretta sicuramente fa male, non fa bene. Però facendo tanto sport riuscivo a compensare. faceva comunque male fumare, ma un po’ meno. Oggi, ogni tanto fumo ancora le sigarette normali, ma quasi esclusivamente le elettroniche. E devo dire che con i polmoni sto molto meglio”.
Hai detto che oggi non trovi più il calcio che piace a te. Cosa manca e, se potessi, da dove cominceresti per cambiarlo?
“Partirei da certi valori che una volta c’erano. Ai miei tempi i genitori ti mandavano a giocare a calcio perché faceva bene al fisico. Oggi ti mandano a giocare a calcio perché devi diventare professionista. È diventato quasi un conto corrente. I genitori sono i primi tifosi, pagano per i figli. È un calcio diverso. All’epoca lo facevi per salute. Poi, se diventavi calciatore, era tutto di guadagnato. Ma si partiva da lì”.
Oggi si parla tanto di capitani, di gruppo squadra, ma lo spogliatoio ha un’accezione molto diversa rispetto ai tuoi tempi. Com’è cambiato questo aspetto?
“Una volta c’erano le famose bandiere: giocatori che restavano nella stessa squadra per 5, 6, 7, anche 8 anni. Diventavano parte della società. Quando arrivava un nuovo giocatore, trovava subito l’appoggio di questi veterani: gli insegnavano come muoversi nella città, dove andare a mangiare, dove lavare la macchina. Conoscevano tutto. Erano punti di riferimento, e non solo nello spogliatoio. Contavano anche verso la società, per i premi, per chiedere magari un giorno in più di vacanza. Erano uomini in più. Oggi invece non credo sia colpa dei club, ma più della mentalità. Mi sembra che ogni giocatore giochi per sé. L’obiettivo di squadra resta la vittoria, ma ognuno guarda al proprio rendimento. Se un compagno è in difficoltà a due metri da te, spesso non lo aiuti. Una volta ti correvano incontro. Anche se segnava l’altro, sapevi che ti aveva aiutato. Oggi ognuno cura il proprio orticello. Una volta erano 11 operai per un’unica ditta. Oggi mi sembrano 11 ditte diverse che giocano insieme”.
Da vice allenatore del Red Block in Kings League, cosa ne pensi di questi nuovi format?
“È un calcio diverso, però è un calcio bello. Da vice allenatore del Red Block, campione dell’Agoth, ho già vinto un torneo di questi. L’ho vissuta in maniera positiva, bellissimo, un ambiente stupendo con ragazzi straordinari. Le partite sono tutte in bilico fino alla fine: con le regole che ci sono, non è mai finita. Puoi vincere 3 a 0, poi ti tolgono un giocatore, poi c’è la famosa carta… Sono partite che ti danno entusiasmo fino all’ultimo secondo, non hai mai vinto e non hai mai perso davvero. E soprattutto vedi giocate bellissime. Ci sono ragazzi tecnicamente molto forti, magari non professionisti ma di categorie inferiori, che fanno cose davvero notevoli in questi campetti a sette”.
Secondo te anche giocatori di Serie A o Serie B potrebbero essere attratti da questo tipo di calcio?
“Secondo me sì, anche se giocare a sette e giocare a undici sono due sport completamente diversi. Però un giocatore forte in Serie A o B può comunque far bene. Certo, cambiano i tempi di controllo palla, i movimenti, lo spazio… Io, con le mie caratteristiche, avrei fatto un po’ di fatica”.
Tornando alla tua carriera: hai sempre detto che la mancata convocazione in Nazionale ti ha lasciato un po’ d’amaro in bocca, soprattutto dopo l’infortunio di Vieri che sembrava potesse essere il tuo momento…
“Mi è dispiaciuto non aver fatto nemmeno una presenza in Nazionale, però so benissimo che negli anni ‘90 e nei primi 2000 c’erano tantissimi attaccanti. Mi viene in mente Montella: era uno che faceva 15-20 gol in Serie A ogni anno, e non è che ha giocato tantissimo in Nazionale. Quindi c’erano tanti attaccanti più forti di me. Però, per quello che ho visto negli ultimi vent’anni… Diciamo che in Nazionale ci hanno giocato tutti. Una volta ha giocato in Nazionale uno che non aveva nemmeno debuttato in Serie A. E poi ci chiediamo perché non andiamo ai Mondiali. Il motivo c’è. Non è un problema, ma dovremmo iniziare a farci qualche domanda”.
E a proposito di Nazionale, uno dei temi ricorrenti è la mancanza di attaccanti italiani. Secondo te dove risiede il problema?
“Il problema è semplice: parte dal settore giovanile. Negli anni ‘90, ad esempio, la Primavera dell’Inter era composta da 25 lombardi, o comunque ragazzi della provincia di Milano. Il Brescia aveva 25 bresciani o giù di lì, la Cremonese lo stesso, la Roma aveva romani o laziali, il Napoli napoletani o campani. Tutte le Primavere delle squadre di Serie A ogni anno buttavano fuori 18 portieri, 18 terzini, 24 centrali, 50 centrocampisti… E di questi, qualcuno buono veniva sempre fuori. Se guardiamo oggi, il 75% delle Primavere di Serie A e B sono composte da stranieri. Quindi è normale che ci siano tre portieri e bisogna sperare che almeno uno sia bravo. Prima c’erano tante scelte, e tanta concorrenza. Dovevi essere bravo sul serio per emergere. Se eri uno dei 17 centravanti della Primavera, per essere chiamato in Nazionale dovevi essere molto più bravo degli altri 16. Adesso ce ne sono due o tre, basta fare un paio di gol e ti chiamano perché sei rimasto solo tu. Ci vuole uno studio, una struttura. Se prendiamo solo stranieri per farli giocare nel nostro campionato Primavera, a quel punto non serve a niente per la Nazionale o per le stesse società italiane”.
Tu hai rifiutato la Premier League. Oggi, invece, vediamo un attaccante come Retegui che a 26 anni sceglie l’Arabia Saudita. Che lettura dai a questa scelta?
“Io rispetto tutte le scelte, sono personali e ognuno deve fare quello che ritiene giusto. Ai miei tempi era diverso: non c’era tutta questa mania di andare all’estero. Io stavo bene in Romagna, mio figlio andava all’asilo, non volevo scombussolare la famiglia, poi non sapevo nemmeno a cosa andavo incontro. Sicuramente a livello economico sarebbe cambiata la mia vita, ma io mi accontentavo comunque di quello che prendevo. Rispetto a quello che prendevo a 20 anni, ero già felice. Oggi il calcio è cambiato, ci sono queste offerte… E io dico sempre: beati loro! Se uno prende 20 milioni per giocare un anno, beato lui. È una scelta che ha fatto e posso capirlo, soprattutto se sei un giocatore che magari non ha ancora fatto il salto definitivo. Su Inzaghi, ad esempio, mi è piaciuto un po’ meno. Un allenatore come lui, che allena già da qualche anno, ha già fatto tanti contratti… Credo che abbia messo via un bel gruzzoletto. Andare lì due anni… Magari vuole farsi un’esperienza, però ecco, mi è piaciuto un po’ meno. Retegui invece può tornare in Italia fra due anni con 40 milioni in più. Si sistema lui, sistema la sua famiglia. È una scelta che ha fatto, e la rispetto. Io magari avrei fatto un bel biennale o triennale con l’Atalanta a 4 milioni l’anno — che non sono pochi, anzi — e mi sarei accontentato”.
Rimaniamo sul tema centravanti italiani. Camarda è appena arrivato a Lecce. Da ex attaccante, che idea ti sei fatto sulla gestione dei giovani in Italia e su di lui in particolare?
“Deve crescere, deve giocare. Io credo che un giovane così deve crescere giocando. E la scelta del Lecce, come società, è buona. Di Francesco lo conosco, è un allenatore che fa crescere tanti giovani. Ma per farli crescere, devono giocare. Io, fossi stato in Camarda, avrei preferito andare in Serie B a fare 35 partite, piuttosto che andare in Serie A a fare venti spezzoni a partita iniziata. Non credo che parta titolare. Per cui avrei scelto una categoria inferiore: mi sarei fatto le ossa, l’esperienza”.
Un centravanti che ha fatto questa scelta è Pio Esposito…
“Sì, ha fatto bene. Ha fatto benissimo quest’anno e si è rilanciato. Quello è stato un anno di esperienza, non lo chiamo purgatorio, ma sono quegli anni che ti fanno crescere. In B c’è più cattiveria, impari tante cose, e soprattutto… Giochi. Giochi di continuo, e migliori. Perché se giochi venti minuti una partita, poi stai fuori due, poi ne giochi altri venti… Sì, ti serve, ma è relativo. Se invece fai 90 minuti ogni domenica, prendi le botte, rivedi dove hai sbagliato, ti alleni in un certo modo, sei mentalmente sempre concentrato… È lì che cresci davvero”.
A proposito di Inter, il l tuo debutto in Serie A col Brescia, arriva contro i nerazzurri di Ronaldo. Segni anche, ma Recoba ti “rovina” la festa. Che ricordi hai di quella giornata?
“Ricordi bellissimi. A parte la notte prima, in cui sono stato sveglio di più perché c’era stato l’incidente di Lady Diana, e fino alle quattro del mattino sono rimasto a guardare la televisione per seguire le notizie… La soddisfazione più grande però è arrivata quando sono entrato a San Siro per il sopralluogo prepartita un’ora e mezza. Vedere lo stadio strapieno… Tutto esaurito per il debutto di Ronaldo… È stata un’emozione grandissima. Io che ero abituato ai 15-20.000 spettatori, trovarmi davanti a 85.000 persone è stato qualcosa che ti ripaga di tutti i dieci anni di gavetta, dalla Serie C alla Serie A”.
E in quel Brescia, tre anno dopo, arriva Carlo Mazzone. Che ricordo hai di lui?
“Mazzone era un allenatore vecchio stampo, terra terra, onesto. Era limpido nei suoi commenti: se giocavi bene, te lo diceva. Se giocavi male, ti massacrava. Non aveva peli sulla lingua, ma quello che pensava te lo diceva in faccia, e accettava anche le tue risposte, senza problemi. Era una persona squisita, che ti faceva stare bene. E quando trovi un allenatore che ti dice le cose come stanno, è la cosa più bella, perché sai che ti puoi fidare di lui ciecamente. Lui aveva questa fissa del saluto. Quando lo vedevi a 50 metri, dovevi gridargli ‘Buongiorno mister!’ subito, se no si arrabbiava come una bestia. Dovevi salutarlo tu per primo, sempre. E poi ti rispondeva”.
E con Baggio? Com’è stato condividere lo spogliatoio e il campo?
“Roberto è stato un amico, un ragazzo umile. Quando è arrivato, non ci sembrava vero. Noi eravamo abituati a giocatori semplici, modesti, da battaglia. E lui invece era di un’altra categoria: aveva vinto, era conosciuto in tutto il mondo, era un giocatore di livello superiore. Però si è messo nello spogliatoio come uno di noi. Ci si divertiva, ci si allenava, si scherzava. Era un ragazzo splendido. Umile”.
Nel 2002 invece c’è stata quella breve parentesi con il Milan, durante la tournée americana. Com’è andata e perché non si è concretizzato l’approdo in rossonero?
“Non sono approdato perché mi pare che il Piacenza avesse chiesto dei giovani ma il Milan non aveva i giocatori giusti per il ruolo che serviva. Però come esperienza è stata bellissima. Dodici giorni in un grande club, organizzato, con grandi campioni. Anche se c’erano i Mondiali, c’erano Serginho, Leonardo, era arrivato Shevchenko… Giocatori importanti. Mi ha colpito tantissimo l’organizzazione. E poi quei due allenamenti a Milanello… Entrare in quegli spogliatoi dove si erano cambiati Baresi, Maldini, Albertini… mi venivano i brividi. Quando calpestavi il campo, vedevi la statua di Nereo Rocco dietro che ti guarda… Ti emozionava davvero. Una volta per noi quei ricordi, quei giocatori, erano dei punti di riferimento. Erano visti come degli eroi. Quando vedevi Baresi, Maldini, Costacurta… Era una cosa che ti colpiva dentro. Oggi non so se per i ragazzi sia la stessa cosa”.
Nel Milan oggi vediamo Modric che gioca ancora a 40 anni. Se potessi tornare indietro, avresti prolungato anche tu la carriera?
“Ma no, io credo che quando arriva il tuo momento, devi smettere. Io ho giocato fino a 38 anni tra i professionisti, poi mi sono divertito fino a 42. Però a certi livelli devi stare bene fisicamente. Poi ci sono ruoli e ruoli. Il mio, quello della punta, era un ruolo dove dovevi correre, dove contavano forza e velocità. Quando ti mancano quelle cose lì, fai fatica. Uno come Modric, nel suo ruolo, può starci ancora tranquillamente. Ma il mio tipo di calcio era diverso”.
Hai mai pensato di tornare nel mondo del calcio?
“Facile che ci torni proprio come allenatore…”